Nel 1625, il vescovo di Catania, Innocenzo Massimo, decide di incrementare le concessioni “ad melorationem” (enfiteusi) delle terre della “Contea di Mascali”
Anno 1625: il vescovo di Catania, Innocenzo Massimo, decide di incrementare le concessioni “ad melorationem” (enfiteusi) delle terre della “Contea di Mascali” (tutte, “1600 Salme dell’antica misura di Mascali”), che furono concesse “quasi per intero” alla “gente Acitana”. Ha, così, inizio la “grande affittanza” (attraverso “concessioni”, mentre prima si davano solo “licenze”) che riguarderà anche la seconda metà del Seicento (soprattutto con il vescovo Michelangelo Bonadies) e la prima metà del Settecento, trasformando radicalmente il nostro territorio sia dal punto paesaggistico che per popolazione (la cosiddetta “Contea”, infatti passerà dai 570 abitanti del 1616 ai 932 del 1651, ai 998 del 1693, ai 10755 abitanti del 1747).
Il primo processo di enfiteusi condotto nella “Contea di Mascali” non per brevi ed isolati atti (già rilevabili, documentalmente per più di quattro secoli antecedenti), ma attraverso un vasto processo tendente, dunque, a cambiare il volto e l’economia del nostro territorio, si dovette, proprio, al vescovo Innocenzo Massimo (1624-1633). Per capire le caratteristiche di questo processo enfiteutico, sono chiare, in proposito, le parole di Gaetano Galvagno: “La più grossa occasione che si fosse mai presentata ai ‘capitalisti’ acesi si offrì nel secolo XVII, allorché il Vescovo di Catania Innocenzo Massimo, nel 1625, decise di incrementare le concessioni, ‘ad meliorationem’, delle terre della Contea di Mascali: terre per la maggior parte ‘brugiate dalla lava’ o boscose, nelle quali il capitale nostrano (acese; n.d.a.) trovò un sicuro investimento e i concessionari l’occasione di accapararsi e di trasformare – avvedutamente e con pochi soldi – in tenute produttive vastissime aree di terreno sciaroso. Il sistema più di frequente adottato consisteva nel prendere a censo annuo, dal Vescovo, una grande estensione di terra, che, frazionata, veniva data in buona parte in sub concessione a terzi con l’obbligo della corresponsione della quota di censo della Curia vescovile e di eseguire in essa i necessari lavori di dissodamento e di piantare a vigna anche la parte che i concedenti si erano riservata. Attraverso questo sistema, semplice e ingegnoso, che ricorda il contratto di ‘pazionaria’ in uso nel mondo medievale, gli speculatori, nel giro di un decennio, divenivano possessori di ubertosi vigneti”. Quindi, ha scritto ancora Gravagno: “1625. La Mensa vescovile di Catania – su disposizione del vescovo mons. Massimo – dà il via alle concessioni enfiteutiche delle terre di Mascali. Secondo una stima quelle ‘terre estese salme 1600 della misura antica di Mascali, divise in 29 parti, furono attribuite per 21 parti agli acesi, per 1 parte ai mascalesi (d’altronde, notevolmente impari, allora, il divario di popolazione fra Aci e Mascali; n.d.a.) e per 7 parti a genti di territori diversi’”.
Chiaro, a tal proposito, il testo di un manoscritto contenuto nella Biblioteca Zelantea di Acireale: “Affinché poi avessero maggiore sfogo queste (genti) Acitane industriose nei passati secoli si concessero dalla mensa vescovile di Catania quasi intero il territorio di Mascali, da Monsignor Maximo l’anno 1623; per atti Notar Alessandro Scudiero si vedono diverse concessioni di dette terre fatte dal suddetto vescovo nell’anno 1623; la quantità di tutto il terreno di Mascali contiene 1600 Salme della misura antica di Mascali, divise in 29 parti, cioè 7 parti esteri, parte I le stesse mascalesi e parti 21 l’Acitani; questa terra pria rendeva scudi 60.000 e si mantengono numerose famiglie per la coltura della vigne e terreni tutti stipendiati dalla gente Acitana, che da sterpo e inculto che era, con grandi attività, spese e fatiche, lo hanno renduto fertile cotanto che le produzioni sono divenute un grosso capo di commercio”.
Ancora, così si legge negli Atti dei giurati acesi: “E solo si fa il Magistrato onore rapportare i fatti di Monsignor D. Innocenzo Massimo (1624-1633) dell’anno 1625 tempo in cui per giusto compenso delle cennate fatiche dei possessori, che beneficiato aveano in maggior parte suddette terre, bosco, quelli preferì, confirmando le loro antiche, ad una solenne concessione in forza di pubblico documento, costituendole un perpetuo canone di tarì 12, per salma ed inoltre, ad instar census, le solite decime di vettovaglie e vini mustali colla riserva delli lodemi, in caso di traslazioni e patti domenicali che in esse concessioni si leggono stipolate per atto di pubblico notaro, giusta la consuetudine ed osservanza. Cotal sistema fu seguito ancora da Mons. Fra D. Michelangelo Bonadies il quale coll’istessa premura che data si avea il suo predecessore di Massimo, passò a fare le nuove concessioni per ridurre non meno detto bosco e Contea fruttiferi ed altresì il Regio erario aumentato nei suoi vantaggi e diritti”.
La “grande affittanza” ha, così inizio. Nella “Relazione” di Francesco Garnier, sullo stato della Contea di Mascali, datata 1843, vengono indicati gli anni in cui maggiormente ebbero ad effettuarsi le grandi concessioni enfiteutiche nel nostro territorio: “Nell’anno 1625, 1626, 1627 e 1694 altre concessioni vennero formate sul tenore della precedente.
In una nota del 1850 (“Memoria per possessori di terre nella Contea di Mascali”), si legge: “Non si può precisare quanto la somma del censo primitivo quanto del secondo canone distintamente per ciascuna salma dell’antica misura e per varie ragioni scrivo tanto la cifra del primo quanto quella del secondo, non sono generali per tutte le terre e differiscono secondo la qualità e situazione dei terreni e secondo le epoche delle concessioni; perché non vi ha elemento in archivio che facci riconoscere qual si era il censo che pagavano in denaro gli enfiteuti pria del 1625 non esistendo scrittura che a tale epoca avesse rapporto e solo dalle concessioni del 1625 si conosce l’obbligo assunto dagli enfiteuti di pagare tarì 12 a salma di canone oltre del primo censo, però dal nesso di vari elementi posteriori è rilevabile che in tutto le due cifre del primo e secondo canone non oltrepassano tarì 24 salma dell’antica misura e da ciò ne consegue che il primo censo doveva essere di tarì 12 salma perché le concessioni del 1625 che sono le più numerose indicano il secondo canone per 12 salma, ed è da osservare che precedentemente al 1625 gli enfiteuti non si avevano concessioni ma semplici licenze dei Vescovi e che le concessioni vere con tutte le forme di enfiteuti ottennero mercé l’obbligo del secondo canone del 1625 in poi, che infine i libri esistenti in archivio sono posteriori al 1764 ed indicano il censo in cifra complessiva delle terre sino allora concesse”.
Questo è, dunque, il periodo della “grande affittanza”, che durerà più di un secolo: Più che gestire in proprio l’economia del territorio, preferirono darlo in affitto (come riporta la sopracitata “Memoria…”) “assieme a tutti i diritti e le preminenze (che; n.d.a.) vi esercitavano; eccetto la elezione dei giurati, dell’acatapani e del maestro notaro, ed il bosco grande e l’altro detto del Carponeto che riserbavano per loro”. In merito al “bosco del Carponetto”, Sebastiano Catalano ebbe a scrivere: “Sappiamo altresì che i vescovi escludevano e non ritenevano gabellabile il bosco del Carponetto, in altra parte della Contea. Il bosco aveva bisogno di cure e di sorveglianza al fine di preservarlo dagli ‘usurpatori’ (termine del De Ciocchis) che, per ingrandire la concessione, privatizzavano – per così dire – ‘petium nemoris’”.
Per più puntuali approfondimenti sull’argomento e per i relativi riferimenti bibliografici: Antonino Alibrandi, “Mascali e il suo territorio – La Storia – Dai Bizantini a Carlo III di Borbone (535-1759)”, Kindle Amazon, Leipzig, 2023, pagg. 268-273.
Antonino Alibrandi







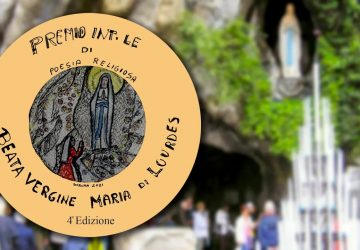













 I NOSTRI INDIRIZZI E-MAIL
I NOSTRI INDIRIZZI E-MAIL

 LINK
LINK CONTATTI
CONTATTI