L’ultima ricerca di Graziella Messina dal titolo La lezione di Josephine, Torri del Vento edizioni, è un’accurata ricerca sulla straordinaria storia di Giuseppa Di Mauro emigrata in America da Trecastagni, all’inizio del Novecento.
Qualche anno fa l’autrice mentre ordinava la documentazione del Museo dell’Emigrazione di Giarre, di cui è Direttrice Scientifica, si trovò a ripercorre un filo documentale che la condusse a scoprire un’intera comunità di emigrate e emigrati di Trecastagni, paese etneo, stabilita a Lawrence del Massachusetts, tra cui la famiglia di Giuseppina Di Mauro, nata nel 1908.
La piccola Giuseppa, partita a soli quattro anni per questa città americana, non sa ancora che diventerà la prima maestra della città che l’ha accolta, lo sa la madre Orazia che con tutte le sue forze volle che sua figlia studiasse per diventare maestra. Giuseppa non si sentì mai plagiata dalla madre, perché per tutta la vita le fu grata per i suoi studi, che la portano negli anni ad acquisire lauree, e per la sua amata professione di insegnante.
Josephine, come si chiamerà nella sua seconda patria, ha depositato nel 1997 al “Lawrence History Center”, centro di documentazione degli immigrati, il memoriale della sua intensa esperienza di maestra, e poi di direttrice e di formatrice. La donna è consapevole della sua grande forza di emigrata siciliana, che per la stessa comunità americana costituisce una avanguardia femminista. Non a caso ha desiderato che la sua storia professionale venisse conosciuta dalle future generazioni. La futura maestra, inoltre, aveva 12 anni quando in America le suffragiste vinsero la battaglia per il diritto al voto, e le associazioni femministe nella vicina Boston non mancavano.
Il memoriale di Josephine rintracciato, in modo rocambolesco, tradotto e pubblicato nel testo da Grazia Messina, appare di una estrema e sbalorditiva modernità. Josephine ci racconta le immaginabili lotte, a partire dal padre che la voleva operaia in una delle fabbriche della città, motivo per cui la famiglia era emigrata.
Il memoriale di Josephine è scritto con intelligenza, arguzia e ironia nel ricordare le figure delle maestre: malpagate e sottoposte a molti disagi da affrontare, soprattutto se destinate alla scuola rurale, che costituì la sua prima esperienza di classi multiple.
La nostra maestra, però, trasformò il disagio in un un’occasione professionale di crescita, ricorderà sempre l’esperienza delle classi multiple come anticipatrici di quelle che quarant’anni dopo saranno chiamare classi aperte.
Le maestre, ai tempi di Josephine, non sottoscrivevano un contratto di ruolo ma contratti a termine, dovevano restare zitelle, il loro comportamento era controllato dalla comunità, spesso puritana, dove risiedeva la scuola. Josephine, infine, doveva fare i conti con la mentalità siciliana del suo quartiere Tanti sono i ricordi delle sue esperienze scolastiche, per lei tutte importanti. Ricorda anche qualche scherzo da parte degli alunni, tutte esperienze che assumevano un profondo significato di relazioni.
Josephine, che visse oltre cent’anni, nel suo memoriale non può fare a meno di paragonare la sua scuola con quella odierna. E’ un’operazione condotta con critiche verso il presente ma senza nostalgie verso il passato.
Giuseppa di Mauro, nel frattempo assunse il cognome del marito diventando Josephine G. Delva. La vicenda personale di Josephine, che assurge al simbolo del riscatto emigratorio soprattutto femminile, da Grazia Messina è contestualizzata nel corso generale della storia, nel caso specifico nella crisi dell’economia contadina e nella conseguente emigrazione non solo dalla zona di Trecastagni, dove La filossera, che aveva divorato le radici delle viti, scompose il mondo già duro dei siciliani dell’inizio del Novecento.
Era già in atto un flusso migratorio verso la lontana America, quando la famiglia Di Mauro, costituita dai coniugi Cirino e Orazia e dai figli Giuseppa e Alfio, affrontò la crisi con l’emigrazione con meta la città di Lawrence. Scelta inusitata, ma che permise alla famiglia un iter di accoglienza meno traumatica rispetto a quella dell’arrivo a Ellis Island. La città era giovane, strategicamente insediata lungo il suo fiume Merrimak utilizzato per il fabbisogno di energia necessaria alle fabbriche tessili, le mills.
Per potenziare la città urbana e soprattutto per produrre in fabbrica era necessario trovare forza lavoro soprattutto femminile, perché sottopagata. Il lavoro non era facile, anzi durissimo tanto che nel 1912 un durissimo sciopero, denominato “Il Pane e le Rose”, come il verso del poeta James Oppenheim, assunto come slogan rivendicazionista dei diritti non solo salariali, scosse la città di Lawrence. Proprio quell’anno la piccola Giuseppa Di Mauro con la famiglia sbarcò dal piroscafo a vapore nella nuova città.
La fase dell’inserimento ed adattamento al nuovo contesto sociale, definito da Grazia Messina “mondo plurale”, non fu facile per la famiglia Di Mauro, anche se il padre, dopo qualche problema di lavoro, ebbe l’iniziativa di sfruttare la sua professione di artigiano marmista, la madre come tante altre donne andò a lavorare in fabbrica. Le diverse lingue, religioni, tradizioni e mentalità che si potevano incontrare nella città non si traducevano in un confronto o osmosi tra i gruppi. Nei vari blocchi dei caseggiati, si insediarono le diverse comunità di emigranti della stessa nazione e regione d’origine. Ogni gruppo desiderava conservare la propria storia, tranne acquisire la nuova lingua per potere comunicare fuori dal gruppo e dalla famiglia. Nel quartiere della famiglia Di Mauro, si tentò di mantener ciò che si è lasciato, per esempio la festa dei tre Santi. Nel 1921 fu costituta la “St. Alfio society” per il culto e la festa dei Tre Santi: S. Alfio, S. Cirino e S. Filadelfo. Le statue dei tre Santi arriveranno direttamente dalla Sicilia.
Lawrence, però, è anche la città delle scuole che furono per le bambine e i bambini occasioni di incontri con le comunità locali, i futuri americani soprattutto saranno formati secondo la cultura e i valori del nuovo mondo.
Il testo di Grazia Messina per mantenere la leggerezza, in senso calviniano, della pagina non riporta nessuna nota esplicativa, nonostante il rigore storico con cui è stato scritto, supportato da una minuziosa bibliografia.
L’autrice Messina ci consegna, pure, il percorso con cui, con cui ha avuto copia tra le mani il memoriale All for love of teaching, Tutto per amore dell’insegnamento. Sono stati il figlio, Fabrizio, e Maria Luisa, amica del figlio, a ritirare la copia dal “Lawrence History Center”. I due giovani al momento della scoperta si trovavano a Boston, entrambi per le loro ricerche scientifiche nel campo della fisica e della medicina. Fu facile per l’autrice incaricare i due giovani a recarsi nella vicina Lawrence per il ritiro del prezioso manoscritto.
Grazia Messina, però, prima di introdurre la ricerca, gioca con la realtà immaginando che a far venire fuori i documenti siano stati Fabrizio e Maria Luisa, ricercatori di studi sull’emigrazione. Immagina, ancora, il loro trepidante viaggio da Boston al “Lawrence History Center” per i loro studi sull’emigrazione. Immagina l’incontro con la reale e disponibile archivista, Aminta, che dà loro accesso a molti documenti e al memoriale di Josephine G. Delva.
L’autrice del memoriale aveva chiesto al momento della donazione al Center che venisse riportata nella scheda la sua famiglia di origine e che era stata la prima insegnante della città di Lawrence. Si innescò, allora, nei giovani il desiderio della consultazione di altri documenti per comprendere meglio la vita di Giuseppa – Josephine. I due giovani ricercatori torneranno a Boston con la copia del memoriale, e con molti interrogativi storici.
In realtà sono gli interrogativi di Grazia Messina, come in realtà saranno Fabrizio e Luisa a consegnarle in Sicilia il memoriale, gesto che assume la valenza simbolica del ritorno di Giuseppa Di Mauro nella sua terra originaria.
Grazia Messina emblematicamente affida la ricerca dei documenti e gli interrogativi ai due giovani, due emigrati intellettuali realmente impegnati nel campo scientifico. Questo gioco tra realtà e finzione sta a sottolineare la valenza dei nuovi emigrati, provenienti soprattutto dell’area accademica, oggi accolti dall’America come risorsa da rispettare, da valorizzare e da retribuire adeguatamente per lo sviluppo e il progresso americano e globale. Si deduce, allora, che se le condizioni sociali e culturali degli emigrati siciliani oggi sono diverse, nella maggioranza dei casi la motivazione che induce i giovani ad emigrare e ad impoverire il Sud è sempre quella: la mancanza di lavoro.
Nunziatina Spatafora



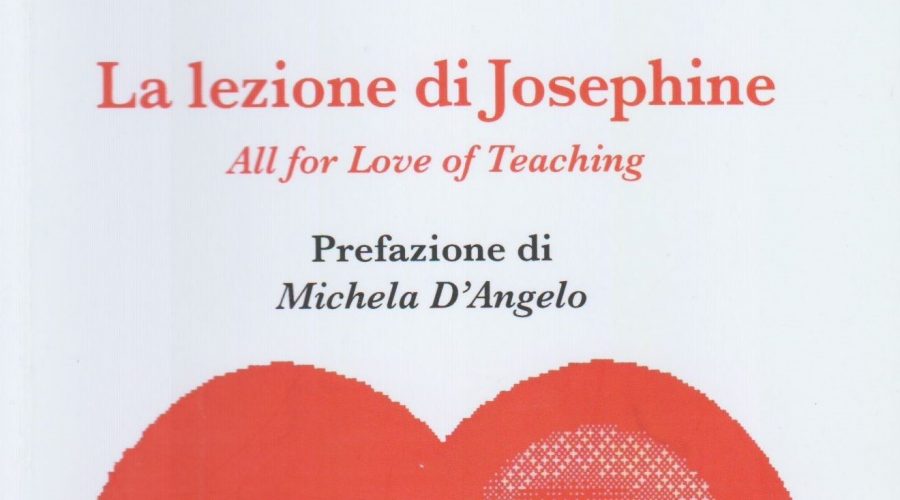


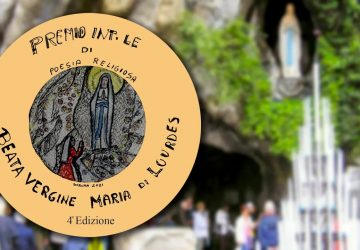













 I NOSTRI INDIRIZZI E-MAIL
I NOSTRI INDIRIZZI E-MAIL

 LINK
LINK CONTATTI
CONTATTI